di Costanza Fusi
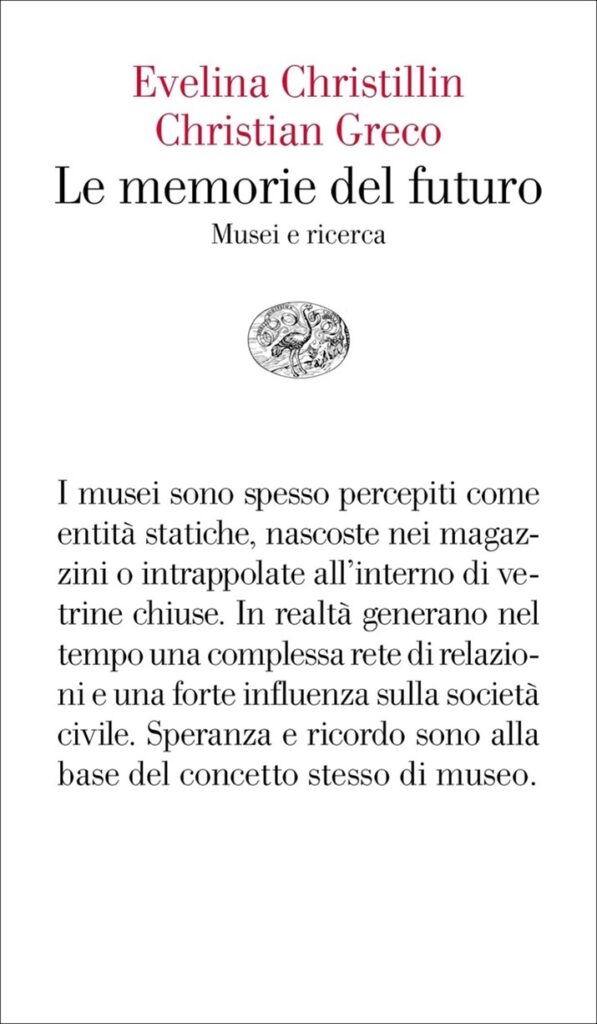
Evelina Christillin – Christian Greco, Le memorie del futuro – Musei e ricerca, Einaudi, Torino 2021
Pubblicato nel 2021 per la collana Vele Einaudi, Le memorie del futuro. Musei e ricerca, è un breve, essenziale contributo che riflette sul ruolo dell’istituzione museale nella contemporaneità, esplorando vari aspetti delle dinamiche storiche e sociali che la vedono protagonista.
Il testo, scritto a quattro mani da Evelina Christillin e Christian Greco – che rispettivamente occupano dal 2012 e dal 2014 le posizioni di Presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie e Direttore del Museo Egizio, di Torino – trova il suo perfetto collocamento in un panorama, di lavoro sul campo e di ricerca accademica, che ormai da anni promuove interventi di ripensamento e trasformazione della cultura, del patrimonio e delle politiche e poetiche, per citare Ivan Karp e Steven Lavine (1991), legate ai musei. Dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso, infatti, con l’avvento del movimento della New Museology (Vergo, 1989), i musei si sono riscoperti attivi protagonisti del loro tempo, sempre più in aperto dialogo con la società che li ospita e della quale essi sono, si potrebbe dire, lenti e specchi. Scandagliati nelle loro strutture fisiche e concettuali, costantemente subiscono – e pianificano essi stessi – trasformazioni che agiscono sull’istituzione in profondità, sia dall’esterno che dall’interno. Trasformazioni spaziali, che coinvolgono gli edifici museali stessi, le connessioni instaurate con il paesaggio urbano in cui si inseriscono e le modalità espositive del patrimonio che conservano e valorizzano; ma anche trasformazioni relazionali, nella continua ri-definizione dei rapporti con le comunità e i loro molteplici stakeholders (quali pubblici, collezionisti, curatori); trasformazioni di valore e significato, infine, della cultura materiale custodita tra le loro mura. Mutamenti che forniscono di volta in volta, come sottolineano gli autori, nuove chiavi interpretative per le fondamentali definizioni di memoria, di patrimonio e di identità.
Molto efficace la struttura del testo, capace di rendere una visione d’insieme dell’ampio sistema di relazioni che coinvolgono l’istituzione museale a 360 gradi. Cinque i capitoli proposti, dai titoli concisi – I. la memoria; II. la storia; III. il presente; IV. gli oggetti; V. il futuro prossimo – che definiscono i temi generali sui quali si srotola il fil rouge di pensiero seguito dagli autori.
In poco più di un centinaio di pagine, con grande capacità di sintesi, Evelina Christillin e Christian Greco raccolgono e condensano le tante riflessioni che accompagnano il loro lavoro quotidiano. Al centro di queste ponderate meditazioni, una visione del museo che non è soltanto un frutto del passato, e neanche, al contempo, soltanto un organismo attivo, oggi, nel presente; un museo, invece, che da sempre è in continua evoluzione, che trasforma sé stesso e i suoi oggetti nel tentativo concreto di proporre nuove relazioni con la società e nuovi modelli per la sua comprensione. Si tratta di un campo oggi in fase di grande esplorazione: infatti, attenzioni sempre nuove e diverse – e una gestione spesso purtroppo al di là delle stesse capacità dell’istituzione – sono necessarie per esplorare i rapporti che il museo costruisce e intrattiene con i suoi pubblici, con le comunità d’origine dei manufatti, e soprattutto con gli studiosi.
Come già dichiarato dal sottotitolo, permea infatti l’intero testo un’attenzione particolare al ruolo della ricerca in relazione al museo. Quale ruolo deve e può mantenere l’attività di ricerca nello spazio di lavoro del museo? Nell’analisi dei due autori, il compito primario del museo è la ricerca stessa, l’unica vera strada possibile per il futuro, finalizzata ad una conoscenza fortemente multidisciplinare del patrimonio. Ciò che non si conosce, si perde. L’oblio è un rischio che grava costantemente sulla cultura materiale. Si chiedono quindi a tal proposito Evelina Christillin e Christian Greco: «i musei concorrono alla morte delle opere che ospitano nelle loro collezioni o sono l’ultimo baluardo perché esse possano sfuggire alla fine di un’esistenza messa in pericolo da una miriade di fattori quali oblio, mancanza di risorse, conflitti, disastri ambientali o più semplicemente incuria?» (p. 56). Contrari a quel filone di studi che ha visto il museo archeologico spesso e volentieri esaltare le qualità estetiche della cultura materiale, isolandola pertanto dal contesto originario e trasformandola in opera d’arte – il cosiddetto “effetto museo” – i due autori esprimono chiaramente la loro opinione. Le memorie, testimonianze materiali del passato, se mute, dimenticate sugli scaffali o abusate e decontestualizzate, restano invisibili. I musei devono pertanto prendere posizione e lavorare per reimmergere nella Storia i loro oggetti, raccontarli offrendo al pubblico la loro – il più possibile – completa rete di connessioni e la loro temporale profondità, al fine di fornirne una chiave interpretativa, e favorire e promuovere pertanto una comunicazione estetica, visiva e intellettuale del patrimonio che, con riferimento forte a quello antico, mancherebbe altrimenti di voce propria.
Interessante sottolineare che, esplorando a più riprese il concetto di agency riferita agli oggetti (Gell, 1998), gli autori indagano anche il rapporto strettissimo, co-dipendente – e per questo motivo anche talvolta limitante – tra istituzione e cultura materiale, sottolineando al contempo il classico conflitto tra la necessità di conservare il patrimonio fisico, come testimonianza dell’antichità, e l’esigenza di comunicare attraverso di esso il presente, di renderlo protagonista materiale attivo di dinamiche intangibili in continua evoluzione. Quella dei due autori è una posizione affascinante: «il ruolo dei musei si identifica proprio nel discorso intellettuale che vede filosofi, antropologi e sociologi affrontare le problematicità del presente, cercando di comprendere e comporre il rapporto dialettico tra passato e futuro, tra forze innovatrici e conservatrici» (p. 12). Contestualizzate all’interno di questo dibattito, le azioni del conservare e valorizzare il patrimonio mondiale dell’umanità, compiti dei musei, permettono di comprendere a fondo i meccanismi dei cambiamenti che investono la società. Il museo assume la funzione di ponte tra generazioni, apre uno spazio comune di dialogo tra passato e presente, attualizzando i ricordi.
Da qui, la necessità di soffermarsi a più riprese anche sul concetto di memoria. Oggetto del primo capitolo, la memoria fornisce il punto di partenza per porsi una domanda che ritorna più volte, quasi prepotentemente, tra le righe: a chi appartiene il passato? Molteplici le risposte proposte nelle pagine di Le memorie del futuro, che aprono a loro volta, come immancabilmente succede, spazi per nuove domande: il passato è veramente rilevante per la società contemporanea? Quanto possiamo considerare il passato parte della nostra società e comunità? E soprattutto, quanto del passato è radicato nel presente? «Fornendo in maniera consapevole un significato alla percezione pubblica del passato» (p. 16), ci dicono gli autori, i musei impongono in questo senso una loro visione, non neutrale. Ne sono allo stesso tempo garanti e creatori, e possiamo pertanto considerare la loro azione essenziale nella formazione «e nello sviluppo di una società critica che sappia interrogarsi sulle sfide politiche, sociali e ambientali» (p. 27).
Nella parte dedicata alla storia, (Cap. II) è delineata una vera e propria cronologia essenziale della vita dell’istituzione. Il museo dalle origini ai giorni nostri; una storia narrata per tappe che non perde mai di vista l’obiettivo finale e non tralascia quindi i tanti collegamenti alle dinamiche del presente. Ponendo a confronto le varie definizioni di museo, analizzate criticamente e in correlazione le une con le altre, il testo ripercorre i vari momenti che hanno segnato l’attuale composizione della definizione ICOM, pubblicata a seguito delle consultazioni di Praga nel 2022. Nelle pagine del volume, di definizioni dell’istituzione museo, i due autori ne propongono molte: aggettivi, frasi, interi paragrafi sono dedicati a descrivere ciò che il museo è, potrebbe e dovrebbe essere, analizzando il suo statuto attuale e ponendolo in una relazione critica rispetto ai ruoli avuti in passato e a quelli che avrà in un prossimo futuro. Musei come luoghi di frontiera, «chiamati a rompere il legame identitario fra nazione e territorio» (p. 69). Ma anche musei come laboratori di innovazione, come attori attivi nel definire una memoria collettiva che sappia fornire delle risposte alle istanze che si formano diacronicamente nella società; luoghi, quindi, in cui creare e condividere una memoria collettiva, ma anche dove cercarla, si potrebbe aggiungere.
Invitando i musei a un confronto sui temi attualmente più caldi, i due autori analizzano poi la situazione museologica del presente (Cap. III, V), sottolineando il grande bisogno generalizzato di «fornire risposte efficaci a temi complessi e a questioni etiche divenute sempre più rilevanti» (p. 50) delle quali i musei non possono oggi non curarsi. Toccano quindi il tema delle restituzioni – opportunità per i musei di ripensare il proprio ruolo all’interno delle comunità – inserendole in un discorso polivocale che si serve di alcuni concreti e “mediatici” avvenimenti degli ultimi anni per entrare nel vivo delle complesse relazioni tra musei e «paesi fonte» (p. 65). Protagonisti dell’analisi anche i cambiamenti che la globalizzazione ha portato alle nostre società e che investono il museo e la percezione del territorio nel quale esso si trova ad operare.
Intersecando storia, filosofia, politica, antropologia, e naturalmente gli studi di cultura materiale, che si nutrono di tutte queste discipline, Evelina Christillin e Christian Greco hanno redatto una guida, leggera e approfondita, dedicata a chi dai musei è soltanto attratto e incuriosito, a chi con i musei lavora quotidianamente e a chi voglia entrare in contatto con gli aspetti più critici e le dinamiche più rischiose dei rapporti che questa istituzione intrattiene costantemente con la società.
Una guida che porta con sé anche, infine, un invito a riflettere su cosa il museo può ancora insegnarci, a sviluppare modelli interpretativi che siano validi per il futuro, che ci consentano di arrivare a definire quella che gli autori chiamano una «nuova semantica museale» (p. 113). Vedere il mondo attraverso le lenti dei musei ci permette infatti di muoverci all’interno dei loro lunghissimi orizzonti temporali, imparando a cambiare e ampliare il nostro punto di vista. Facendo ciò, ci poniamo in una prospettiva più completa, capiamo il nostro ruolo nel presente abbracciando il passato, tracciamo una biografia della società senza confini temporali.
Tra gli aspetti del testo meritevoli di considerazione mi preme segnalare il frequente inserimento di riferimenti alla disciplina archeologica e, nello specifico, agli studi di egittologia – di cui Christian Greco è eminente referente nel panorama italiano. Citazioni tratte da antichi testi, vicende storiche narrate con brillante vivacità, richiami a studi approfonditi su oggetti e tradizioni, parallelismi con la società e le usanze della civiltà dell’antico Egitto avvolgono l’intero testo, catapultando il lettore in uno spazio-tempo passato molto diverso da quello contemporaneo, rinfrescante, seppur antico, e che, incredibilmente, senza interferire con il quadro ampio di analisi portato avanti dai due autori, non fa che rendere ancora più concreto e visibile il rapporto con le vicende storiche e sociali contemporanee vissute dall’istituzione.
Un testo che stimola una curiosità particolare, dunque, che propone interessanti intuizioni e che raccoglie in una solida cornice critica le esperienze e le riflessioni personali – e professionali – dei due autori. Con estrema semplicità Evelina Christillin e Christian Greco riportano alla luce in queste pagine concetti complessi e fortemente interconnessi tra loro, condensando traiettorie di ricerca decennali in un quadro chiarissimo, denso di ottimi spunti e riferimenti. Idee concrete di lavoro per un futuro prossimo ma anche, è necessario riconoscerlo, il resoconto di desideri in parte utopici, che – per nostra fortuna – nella mente degli umanisti non svaniscono mai. Per concludere, potremmo quindi solo augurarci che le preghiere dei due autori vengano ascoltate, o meglio, lette.
Fonti citate
Gell, A. (1998): Art and Agency. An Anthropological Theory. Oxford: Clarendon Press.
Karp, I. e Lavine, S. (1991): Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display. Washington and London: Smithsonian Books. Vergo, P. (1989): The New Museology. London: Reaktion Books.