di Giovanni Occhini

Veronica Pesce, Il vasaio e l’ortolano. Giovanni Pascoli, i suoi illustratori, le arti figurative, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2021
Il volontario esilio barghigiano di Giovanni Pascoli del 1895, realizzato in concomitanza del traumatico distacco dalla sorella Ida andata sposa, se da una parte rese più ardui i rapporti diretti con i contemporanei, dall’altra permise alla sua corrispondenza di godere in questo torno d’anni di un’inedita fioritura. Tra i corrispondenti spiccano per notorietà i nomi di molti insigni artisti del tempo, coinvolti da Pascoli nel complesso progetto di illustrazione grafica della propria opera. Da questo enorme corpus di lettere Veronica Pesce ha pensato bene di prendere le mosse per esaminare, ma ancor più indagare da vari punti di vista, l’origine e i caratteri della peculiare cifra visiva che traspare da moltissimi versi pascoliani. Pascoli fu poeta “pittore” per eccellenza, basti pensare ad alcuni “capolavori impressionistici” myricei, ma anche allo spiegato panorama di strutture più ampie, dalla bucolica Sementa dei Primi Poemetti fino all’impasto pittorico dolorosamente preraffaellita dei Poemi conviviali. Per esemplificare una simile attitudine figurativa e la sostanziale complementarietà di arte visiva e letteraria nella poetica pascoliana, la studiosa sfrutta un’immagine del tardo poemetto filosofico-agreste I due vicini, incluso postumo nelle Poesie varie e risalente al 1907. Qui l’ortolano-poeta e il vasaio-artista, i vicini del titolo, vivono in perfetta concordia, conducendo entrambi un lavoro umile, manuale, sostanzialmente “artigianale” e apparentato dall’utilizzo dei medesimi strumenti del mestiere, acqua e terra nella finzione poetica. Da questa suggestiva, fraterna allegoria comincia il libro di Veronica Pesce, quasi un manuale sul tema articolato in due parti. La prima parte, informata di notevole acribia e scrupolo documentario, è dedicata alla fitta trama di vivi confronti dialettici fra scrittore e illustratori (che a tratti assumono l’andamento di piccoli romanzi epistolari). Appoggiandosi al pregresso, puntuale ma disperso lavoro di Paola Paccagnini, Pesce porta alla luce documenti inediti e poco divulgati e riesce a conferire una dimensione unitaria, a trovare un fil rouge all’interno dei variegati e spesso conflittuali sodalizi artistici vissuti dal romagnolo alla ricerca della perfetta resa figurativa delle proprie raccolte. A questo proposito è da lodare l’incredibile dovizia di informazioni d’archivio che l’autrice è riuscita non solo a rendere direttamente reperibile e consultabile, ma ad inserire in un quadro coerente e organico di note e rimandi. Parzialmente inedita si scopre la corrispondenza con i bolognesi Vico Viganò e Augusto Majani, e i numerosi carteggi già pubblicati sono minuziosamente descritti a piè di pagina e messi a frutto nel corpo del testo, a creare un costante colloquio di voci supportato da un apparato iconografico d’eccezione.
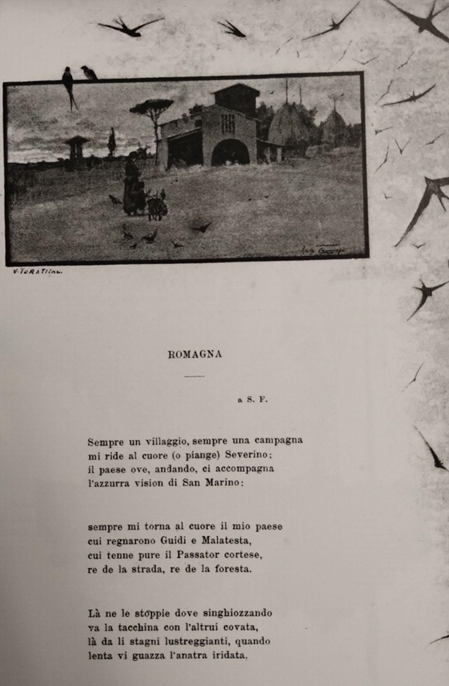
A nostro avviso il massimo pregio del libro risiede proprio nella sua capacità di consegnarci una sistematica rassegna, quasi un repertorio completo, dei multipli e spesso contemporanei dialoghi tenuti dal poeta con artisti suoi contemporanei. Come il poeta coltivava in maniera sincronica vari registri espressivi (la lirica breve delle Myricae e dei Canti di Castelvecchio, la terzina dantesca dei Primi Poemetti, l’endecasillabo sciolto di molti Conviviali), così l’epistolografo si preoccupa costantemente e con passione di fornire veste grafica alle diverse sue “creature”, sia in rivista che in volume. D’altronde Pesce sottolinea come nel gusto pascoliano sia registrabile una costante evoluzione da un sostanziale accordo con la poetica postmacchiaiola e naturalistica dei primi collaboratori come Tommasi e De Witt fino a un parziale spostamento su posizioni più marcatamente estetiste-liberty a cavallo dei due secoli. Il giovane De Witt, a quell’altezza ancora legato a un gusto realistico strettamente debitore dei Tommasi e inizialmente coinvolto nel progetto grafico dell’edizione omnia delle poesie, viene messo da parte in favore del più celebre Adolfo De Carolis. Pesce inferisce giustamente che il gusto pascoliano possa essere stato in questi anni influenzato dal contatto prima con il romano “Il Convito” diretto dall’amico Adolfo De Bosis, e poi dalla raffinatezza dannunziana dei “nobili spiriti” fiorentini, come egli stesso chiama in una lettera ad Angiolo Orvieto i collaboratori del “Marzocco”. Il nuovo indirizzo è ben esemplificato dall’ammirazione nutrita dal poeta per De Carolis, alfiere di uno stile floreale prediletto nei salotti del capoluogo toscano. Sono gli anni dei Poemi conviviali, la cui stilizzazione pseudo liberty ha certo influito sulla richiesta all’incisore marchigiano di eseguire solo decorazioni e non illustrazioni per i frontespizi dell’opera omnia. L’apporto di Vittorio Corcos, già sostanziatosi in uno schizzo preparatorio di Mendico ora nell’Archivio Pascoli di Barga, viene lasciato cadere con il pretesto di difficoltà tecniche di stampa, in realtà in virtù di un disallineamento fra le sensibilità dei due collaboratori. In una dinamica di rapporti che sembra quindi segnata da un sostanziale vantaggio del poeta sull’artista si inserisce lo strettissimo e quasi paritario legame che a lungo unì Pascoli a Plinio Nomellini, raffinatissimo illustratore degli incompiuti Poemi del Risorgimento, oltre che di altre composizioni apparse sulla “Riviera Ligure” di Mario Novaro. I due condividevano un retroterra politico molto simile, dal socialismo anarchico degli anni giovanili fino al lealismo più o meno monarchico della maturità. Nello studio la simpatia del poeta sammaurese per il simbolismo “di transizione” di un Nomellini nato nell’alveo della “macchia” mette bene in evidenza il cambiamento di gusto avvenuto nella sensibilità pascoliana. Degno di nota è poi il risalto dato alla collaborazione con due grafici “minori”: Vico Viganò e Alfredo Baruffi, che nel primo decennio del secolo si occupano rispettivamente di un’antologia pascoliana illustrata, Albo pascoliano (prefata da Leonardo Bistolfi) e dell’apparato iconografico delle enigmatiche, corrusche e incompiute Canzoni di re Enzio. Alla rarefatta resa rembrandtiana delle tavole di Viganò risponde l’erudizione antiquaria e carica di dettagli di Baruffi.

La seconda parte del libro trova nella prima sostegno e avallo a un tempo. Il lavoro, dopo esser riuscito a mostrare quanto capillare ed esigente sia stata la presenza delle arti figurative nella traiettoria creativa della musa pascoliana, si concentra ora nel reperire un adeguato riscontro, un’intima giustificazione nei testi di Myricae. Un’idea di fondo fa da perno all’intero lavoro della studiosa, ovvero l’evidente pensiero visivo che sottende l’intuizione ma soprattutto la creazione del componimento pascoliano. Il Fanciullino pensa per immagini (e sono immagini molto ben definite come si vedrà), “impicciolisce per poter vedere, ingrandisce per poter ammirare” il creato e per trasmutarlo in metafore che spesso in Pascoli attengono alla sfera del visibile. Se questo temperamento icastico del genio pascoliano era già stato evidenziato in passato, meno chiara appariva fino ad oggi la reale e concreta ricaduta che tale teoria aveva avuto sull’officina scrittoria. Può infatti accadere che a un primo approccio il lettore comune non veda nelle schegge di poesia pura di Myricae che rutilanti, accesi frammenti di natura tardo macchiaiola, magari venati di moderna inquietudine dovuta a calibrati innesti simbolisti. Il metodo adottato da Veronica Pesce, consistente in una puntuale analisi stilistico-retorica di alcuni pezzi paradigmatici, al contrario rende palese come tutta l’orchestrazione retorica e fonica della raccolta miri a concretizzare concetti o sentimenti astratti in immagini, visioni percepibili. Il dato cromatico, in virtù di una varia e duttile tavolozza tonale, svolge necessariamente un ruolo centrale. Molto interessante a proposito risulta il rilievo concesso al colore bianco e al suo contrasto con il nero in testi emblematici come Effetto di neve o La baia tranquilla. Ci è dato così osservare come l’opposizione di tinte funga spesso da vettore di angosce quasi sempre legate a un principio di agorafobia patita dal poeta. Sul piano strettamente linguistico la figura retorica “visiva” che è maggiormente indagata è inevitabilmente la sinestesia, che trova il proprio manifesto ne Il miracolo, dove ad ogni strofa un colore è associato a una lettera che si ripete in assonanza. Particolare attenzione è dedicata al cosiddetto “costrutto impressionista”, categoria continiana attraverso cui si antepone la notazione cromatica, pittorica al referente vero e proprio, all’analitica descrizione del soggetto, pervenendo così a una “riproduzione verbale del dipingere impressionista […] per macchie di luce-colore”. Celebri sono il “nero di pece” di Temporale e il “turchino biancheggiare” de La baia tranquilla. Un Pascoli che dipinge con la parola, dunque, e che sulla scorta di simili soluzioni linguistiche è stato via via catalogato, per fare alcuni esempi, come puro impressionista, simbolista, parente stretto di Previati e Segantini (Pesce, attraverso passate ricognizioni di Carlo Sisi, segnala opportunamente le innegabili tangenze in materia di rappresentazione del tema materno). Anche di questa interessante e eterogenea storia critica l’autrice riesce a fornire una precisa panoramica. Emerge così da queste pagine l’immagine di un Pascoli eccezionalmente interessato all’argomento delle arti figurative, al loro attivo e spesso creativo dialogo con il testo poetico, e in cui la propria sensibilità estetica, inquieta e fluida, non manca mai di partecipare di un certo grado di naturalismo.
Questo sotteso gusto naturalistico, pur declinato in chiave simbolista con il prosieguo degli anni, ci fa arrivare a una delle conclusioni più solide della monografia di Veronica Pesce. L’interesse che muoveva Pascoli sul filo di queste corrispondenze era di carattere squisitamente pratico, ossia di fornire un’adeguata e letterale illustrazione grafica dei suoi versi. Estremamente puntiglioso nelle richieste, corredava sovente le missive di piccoli schemi figurativi che i pittori dovevano seguire alla lettera. Si è già fatto cenno a come l’autrice sottolinei la sostanziale ispirazione icastica e attitudine visiva del fanciullino pascoliano, enunciata in poesie esemplari come Il mago e il già ricordato Il miracolo e innalzata a sistema nella celebre prosa de Il Fanciullino. Ebbene, proprio la precisione e la compiutezza della visione mentale del poeta pretendeva che una sua illustrazione vi si dovesse adeguare in maniera totale, ancor più che al testo (che di quella visione era un’imperfetta trasposizione). Di qui l’arduo e contrastato compito dell’illustratore, un compito giudicato dallo stesso scultore Leonardo Bistolfi, amico e collaboratore del poeta, impossibile, visto che la vera poesia “reca [già] in sé gli elementi di una visione materiale fissa nella sua essenza, ma che non può e non vuole essere determinata in un aspetto unico immutabile”. Il saggio costituisce dunque un punto fermo e una pietra miliare nella storia degli studi sul rapporto fra Pascoli e le arti figurative, esaurendo il discorso sulle relazioni tra il poeta e i suoi illustratori e gettando le basi per ulteriori ricerche multidisciplinari dedicate all’analisi in chiave visiva delle altre raccolte poetiche pascoliane, così screziate di colori e cangianti di toni. Il lavoro si distingue per la chiarezza della prosa e per la precisione dell’impianto in due parti, a sé stanti ma al contempo intimamente complementari. Da ultimo piace ricordare un corredo illustrativo eccezionalmente ricco, “parte integrante di questo lavoro”, come ricorda la stessa studiosa.